Un’intervista di Valeria Luiselli alla scrittrice messicana Laia Jufresa, autrice di Umami. L’articolo è uscito originariamente su Bomb Magazine, che ringraziamo.
traduzione di Giulia Zavagna
Una volta Laia Jufresa mi ha dato da leggere un racconto che aveva scritto su un uomo che si sveglia e si rende conto che si è trasformato in un libro – una modesta improvvisazione della Metamorfosi di Kafka. Qualche settimana dopo io ho dato a lei da leggere un racconto – davvero pessimo – che mi ha restituito con un sacco di suggerimenti, proposte di editing e una nota gentile che diceva: «Forse nel tuo racconto ci sono un po’ troppe sigarette e troppi caffè?» Avevamo diciannove anni. Da allora, io e Laia ci siamo scambiate tutti i nostri manoscritti, discutendo nel dettaglio i nostri lavori in caffè di remote città latinoamericane ed europee, o su Skype, godendoci in silenzio la lenta maturazione delle nostre reciproche prose (non ci sono corsi di scrittura creativa in Messico, quindi si fa affidamento sull’infinita pazienza degli amici). Studiavamo insieme filosofia all’Universidad Nacional Autónoma de México, quindi forse ci siamo lette a vicenda con il rigore e la dedizione che abbiamo imparato allora. Posso dire senza ironia che io e Laia ci osserviamo a vicenda con una sorta di «distanza epistemologica». Ci seguiamo e ci facciamo compagnia con un preciso equilibrio di reciproca ammirazione e rispetto, e la capacità di esercitare critiche oneste e severe. Ci mettiamo in dubbio costantemente, anche quando non ci facciamo domande. In occasione della pubblicazione del suo delicato e potente romanzo, Umami, ci siamo viste a Parigi in un piccolo appartamento sull’Île Saint-Louis. Da lì, abbiamo fatto una passeggiata fino alla Shakespeare & Co., dove abbiamo trovato il libro di Laia esposto a sorpresa in vetrina. Quale migliore opportunità per parlare di libri, Messico, e polipi?
–Valeria Luiselli
Valeria Luiselli: Il mio piano era di passeggiare fino alla libreria Shakespeare & Co. e chiederti di scegliere tre libri: uno che è importante per te come lettrice e scrittrice, uno che hai sempre voluto leggere ma non l’hai mai fatto, e un terzo che hai sempre sentito di dover leggere ma in realtà non ti va. Iniziamo con il primo.
Laia Jufresa: Come lettrice, ce ne sono troppi da elencare, ma uno che mi viene in mente in quanto scrittrice è Lo zen e l’arte della scrittura di Ray Bradbury, una raccolta di personal essays che esplorano il suo rapporto con la scrittura. Quel libro è stato incredibilmente importante per me perché mi ha dato la conferma che non sapevo di cercare. Scrivevo già, ma ero anche molto intimidita. Non ho mai davvero letto tutte le cose che bisognerebbe leggere, e cercavo sempre di fingere di averlo fatto, o di dire, «Be’, non l’ho ancora fatto, ma lo farò!» Pensavo di fare qualcosa di sbagliato. L’idea che avrei dovuto leggere determinati libri era un po’ opprimente e non aveva nulla a che fare con il modo in cui scrivevo. Bradbury mi ha mostrato che avevo il diritto di seguire la mia strada, come scrittrice e come lettrice. Lui aveva fatto le cose a modo suo, ed era molto sicuro di sé nel dire ad altri scrittori che andava bene così.
VL: Mi sembri la scrittrice meno professionalizzata del mondo. Ho sempre ammirato tanto la tua libertà di esplorare la scrittura da prospettive molto diverse. Mi ricordo per esempio quel periodo che hai passato a fabbricare cappelli, o scarpe, in Argentina.
LJ: Scarpe.
VL: In qualche modo hai collegato quell’esperienza alla tua scrittura e alla tua poetica.
LJ: Si impara facendo. Bisogna leggere molto per diventare scrittori. Ma non credo che la cosa ci renda necessariamente migliori. Solo scrivere molto ci fa migliorare. Sarebbe ridicolo dire che andare spesso a visitare musei ti rende un pittore migliore. Semplicemente non è così. Ovviamente, ti migliora nel senso che puoi imparare osservando, ma se non ti sporchi le mani ogni giorno con la pittura, non diventerai un pittore migliore.
 VL: Dipingi e disegni da sempre. Hai fatto illustrazioni di libri per l’infanzia. E hai scritto una sceneggiatura. Ti muovi con estrema libertà tra diversi generi e attività. Come si si relazionano con il tuo processo di scrittura?
VL: Dipingi e disegni da sempre. Hai fatto illustrazioni di libri per l’infanzia. E hai scritto una sceneggiatura. Ti muovi con estrema libertà tra diversi generi e attività. Come si si relazionano con il tuo processo di scrittura?
LJ: In molti modi, disegnare mi permette di vagare con la mente, e mi ricorda costantemente la natura dell’artigianato e l’importanza della pratica. Mi ha anche insegnato che la scrittura è l’unica cosa che davvero poterò avanti.
VL: Niente più scarpe.
LJ: Mi piace provare tutto per un po’, e poi smetto. Specialmente la manifattura delle scarpe. Era davvero noioso. Quanto a pittura e illustrazione, che ancora faccio, ci ho messo anni a rendermi conto che andava bene coltivarli come semplici hobby. Dico questo, eppure ho fatto una specialistica in Visual Arts e un master in illustrazione. Da studentessa, ho visto come certe persone potevano passare diciotto ore su un piccolo angolo della loro tela. La scrittura è l’unica cosa su cui posso essere così tanto ossessiva.
VL: Io direi «meticolosa».
LJ: Forse. Cerco comunque di non abbandonare i miei hobby anche quando scrivo a tempo pieno perché mi ricordano a livello subconscio quanto è importante continuare a giocare. Quando dipingo, mi piace farlo a livello dilettantesco – provare sempre cose nuove e sbagliare. Nutre la mia scrittura. Quando inizi a sentire di essere un professionista e hai delle scadenze da rispettare, diventa molto importante essere capaci di continuare a divertirsi e a giocare.
VL: Clarice Lispector aveva un’opinione simile su come il professionismo rovini la creatività delle persone. Posso chiederti cosa significa che ti piace fare qualcosa in modo dilettantesco? Ha qualcosa a che vedere con l’essere straniera? Sei nata in Messico, ma ti conosco da quindici anni e in questo periodo avrai vissuto probabilmente in più di quindici appartamenti diversi tra Europa, Messico e Stati Uniti.
LJ: Credo che non mi stancherò mai di essere una dilettante. Ora voglio scrivere un altro libro, ma a parte questo, ho sempre ricominciato tutto daccapo. Il mio primo libro era una biografia, poi ho scritto El esquinista (The cornerist), una raccolta di racconti, e poi Umami, e poi una sceneggiatura. Credo di creare continuamente uno spazio in cui posso essere una dilettante perché mettermi a fare qualcosa che non ho mai fatto prima è una sfida enorme. Ed è anche molto liberatorio.
VL: Eri molto giovane quando hai scritto le prime bozze dei tuoi racconti, e qualcuno si è offerto di pubblicarli. Ma hai deciso di non farlo perché hai pensato, sono una dilettante, e questa roba non è ancora pronta. Come vedi oggi quella decisione di aspettare a pubblicare, anche se avevi finito un libro?
LJ: Per me non è stata una gran cosa. Non ho mai avuto fretta di pubblicare. Ero molto consapevole che stavo affrontando un processo di apprendimento. Ora, è diverso. Voglio scrivere libri per pubblicarli. Allora, scrivere per me significava solo scrivere. Entravo in libreria e ci trovavo così tanti libri che pensavo, perché pubblicarne uno di cui non sono incredibilmente orgogliosa?
VL: Qual è il tuo rapporto con le lingue in cui scrivi? Sei cresciuta parlando spagnolo, e poi, molto presto, hai imparato il francese. Anche il tuo inglese è impeccabile, e scrivi benissimo in inglese.
LJ: Ora sto anche imparando il tedesco!
VL: Sei costantemente in contatto con diverse lingue. Come nutrono la tua scrittura?
LJ: Allora, scrivo le prime bozze prevalentemente in inglese, e poi le traduco in spagnolo.
VL: Interessante. Perché?
LJ: Perché sono cresciuta leggendo in inglese. Mio nonno viveva negli Stati Uniti, e mi mandava libri da leggere. La lingua che mi viene più spontanea quando inizio un nuovo progetto è sempre l’inglese. Poi lo abbandono appena le cose si fanno serie. Mi garantisce il giusto mix di familiarità e disagio. Sono troppo limitata in francese e troppo a mio agio in spagnolo. In inglese, mi sento più presente consapevole, è come se fossi a casa e non a casa allo stesso tempo.
VL: Io e te siamo due NAFTA kids. Abbiamo vissuto il cambiamento da un’economia chiusa in Messico, dove non si trovava uno Snickers se non al duty-free dell’aeroporto, a un confine aperto. All’improvviso, siamo stati inondati di dolci americani. E dopo, sono arrivati i libri e la musica.
LJ: Il Messico è incredibilmente poroso nei confronti dell’inglese in modi che sono interessanti e molto diversi dalla situazione in altri paesi latinoamericani. L’inglese in Messico filtra a tutti i livelli sociali a causa dell’immenso numero di persone che si spostano costantemente avanti e indietro. Ma non credo che smetterò mai di scrivere in spagnolo.
VL: Gilles Deleuze diceva che tutti i grandi scrittori sono stranieri nella lingua in cui scrivono, perfino nella loro lingua madre. Ti senti straniera in spagnolo?
LJ: Sì, ma probabilmente non quanto te. Non ho vissuto all’estero quanto te, ma non sono cresciuta a Città del Messico, quindi lo spagnolo di Città del Messico mi è sempre suonato un po’ strano.
VL: È difficile parlare un buon chilango.
LJ: Mi sembra sempre di imitare qualcuno, e sono molto emulativa. Un tempo me ne vergognavo. Pensavo che fosse indice di una completa mancanza di personalità.
VL: Io sono sempre stata orgogliosa di esserlo, fino a poco fa.
LJ: Dovresti esserne orgogliosa. Qualcuno mi ha spiegato che ha qualcosa a che fare con i neuroni specchio. Significa che sei molto empatica.
VL: Come i polipi, no? Non sei un’appassionata di polipi? Sono animali straordinari. Sono empatici con gli altri?
LJ: È complicato.
VL: Okay, allora lasciamo per dopo questo argomento perché dovrei chiederti del secondo libro che sceglieresti in libreria, quello che hai sempre voluto leggere e non l’hai ancora fatto.
LJ: Mmm. Direi Il gattopardo, di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che leggerei in inglese. C’è un uso incredibile del narratore onnisciente in terza persona, che nessuno usa più. Ogni volta che mi siedo a leggerlo, dopo poche pagine, la narrazione è così potente che mi fa venire voglia di raccontare storie.
VL: Stai descrivendo un romanzo che è completamente diverso da quello che hai scritto. In Umami ci sono tanto voci diverse, e sono tutte narrate in prima persona o in una terza persona non onnisciente. Tra l’altro, la narrazione è tutto tranne lineare. È frammentaria nella sua composizione. Usi una struttura molto architettonica, perché è basata sulla mappa di un complesso residenziale in cui le case sono posizionate in modo da essere contemporaneamente vicine e lontane. Condividono una sorta di spazio comune, dove le storie e le voci dei vari personaggi si mescolano – una cosa molto tipica di Città del Messico. Allo stesso tempo, il romanzo passa da una voce all’altra, da una casa all’altra. Quindi mi chiedo… perché proprio Il gattopardo?
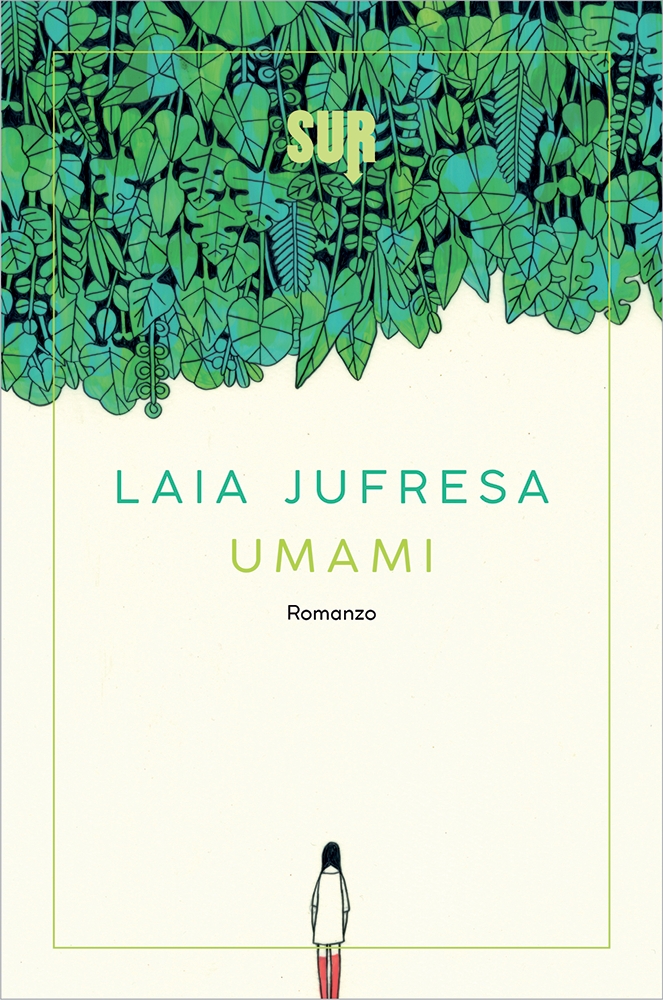 LJ: Non lo so. Quando ho iniziato a scrivere Umami, mi interessava di più essere in grado di costruire una polifonia modesta, non appariscente, che servisse al proposito di costruire personaggi e raccontare la storia, non una parata di voci tanto per fare. Per esempio, uno dei personaggi più importanti del romanzo, per me, è Linda, la madre della bambina che muore. Nel romanzo non parla, ma tutti hanno un’opinione su di lei. E in un certo modo, le loro opinioni sono tutte vere. Siamo tutti così, siamo tutti molte persone diverse. Ma per quanto mi interessi costruire i personaggi in modo graduale, e crearli a partire da un caleidoscopio di opinioni, la storia è l’elemento chiave, e a volte è necessario descrivere le cose in modo veloce ed efficace. Narratori come Tomasi di Lampedusa sono molto bravi a bilanciare la trama e il dettaglio, ed è probabilmente per questo che Il gattopardo mi riporta sempre alla scrittura. È come avere un talento per gli aneddoti. Ci sono persone molto brave a raccontare aneddoti, e altri che proprio non sono in grado, che magari ti raccontano qualcosa di molto interessante, ma rendendolo estremamente noioso.
LJ: Non lo so. Quando ho iniziato a scrivere Umami, mi interessava di più essere in grado di costruire una polifonia modesta, non appariscente, che servisse al proposito di costruire personaggi e raccontare la storia, non una parata di voci tanto per fare. Per esempio, uno dei personaggi più importanti del romanzo, per me, è Linda, la madre della bambina che muore. Nel romanzo non parla, ma tutti hanno un’opinione su di lei. E in un certo modo, le loro opinioni sono tutte vere. Siamo tutti così, siamo tutti molte persone diverse. Ma per quanto mi interessi costruire i personaggi in modo graduale, e crearli a partire da un caleidoscopio di opinioni, la storia è l’elemento chiave, e a volte è necessario descrivere le cose in modo veloce ed efficace. Narratori come Tomasi di Lampedusa sono molto bravi a bilanciare la trama e il dettaglio, ed è probabilmente per questo che Il gattopardo mi riporta sempre alla scrittura. È come avere un talento per gli aneddoti. Ci sono persone molto brave a raccontare aneddoti, e altri che proprio non sono in grado, che magari ti raccontano qualcosa di molto interessante, ma rendendolo estremamente noioso.
VL: Esatto, come me quando racconto le barzellette.
LJ: Ci sono persone in grado di raccontarti piccole cose senza importanza dandogli vita propria. Io credo che la buona narrativa derivi dall’osservazione del mondo e da cosa succede dentro di te. L’opportunità di entrare e uscire da due realtà, il tuo mondo interiore e quello esteriore, è ciò che mi affascina di più della scrittura. Se vuoi semplicemente raccontare storie, ci sono altri modi, altri mezzi per farlo.
VL: Eppure aggiungerei anche che tu non sei il tipo di scrittore che nel guardare il mondo guarda sempre a sé stesso.
LJ: No, ma credo che se hai capito la complessità di un essere umano osservando le tue stesse contraddizioni, sarai in grado di creare personaggi più complessi. L’empatia è un gioco di specchi.
VL: Non mi hai ancora detto se i polipi sono animali empatici o no.
LJ: Non direi proprio.
VL: Che delusione!
LJ: Sono tremendi. Si mangiano a vicenda dopo il sesso.
VL: Magari quella è la più profonda forma di empatia possibile. Secondo me, l’errore del personal essay come genere oggi è che spesso l’aggettivo personal viene interpretato in modo iperbolico. È un modo molto contemporaneo di creare empatia, ma alla fine quanto vuoi vedere te stessa in ciò che scrivi e quanto vuoi vedere gli altri?
LJ: Io non voglio per niente vedere me stessa in quello che scrivo. Sto semplicemente parlando del bisogno di usare sé stessi come cavie. Ma non credo di essere particolarmente interessante – nessuno scrittore lo è, tra l’altro. Penso che per me sarebbe troppo como mirarse el ombligo.
VL: Ombelicale.
LJ: Ho letto scrittori che scrivono di altri scrittori o del loro rapporto con la scrittura in modi che ammiro. Ma personalmente trovo molto più interessante inventare storie. Eppure, non credo che potrei farlo senza aver prima guardato dentro me stessa. Credo che nessuno possa.
VL: In molti modi, Umami è un libro sul dolore. È anche un libro sulla solitudine e l’infanzia. Le voci dei bambini sono ricreate in modo splendido, come lo è il loro mondo, ma sono anche molto tristi per la solitudine alla quale tu sei così abituata. È qualcosa che ti interessava particolarmente esplorare?
LJ: Sì. Quando ho iniziato, ho deciso di scrivere dal punto di vista di personaggi che non avevano figli. Quando la mia raccolta di racconti è stata pubblicata mi sono resa conto che non c’erano personaggi con dei figli. All’inizio, ho pensato che ciò facesse di me una terribile scrittrice, che semplicemente proiettava le proprie esperienze. Ma alla fine ho deciso di esplorare ulteriormente quella condizione nel mio libro successivo. Tutti i genitori ti dicono che le loro vite e il loro modo di vedere il mondo sono cambiati completamente dopo che hanno avuto un figlio. Se così è – e sapevo che avrei voluto avere un figlio anch’io – perché non esplorare quella condizione fino in fondo finché potevo?
VL: Dovresti leggere Hijos sin hijos (Figli senza figli, ndr) di Enrique Vila-Matas.
LJ: Essere un figlio è quindi diventato uno dei temi principali di Umami, e uno dei molti neologismi del libro: «figlitudine». Ma una volta che avevo trovato le voci narranti, la storia è cambiata. Il dolore è diventato il motore del libro perché la violenza in Messico era diventata insopportabile. C’erano così tante morti e sparizioni. Parlo al passato, ma le cose non sono cambiate.
VL: No, decisamente no.
LJ: Ho lasciato il Messico anni fa perché mi sono trovata in mezzo a una sparatoria. Quattordici persone sono morte a venti metri da me. Non riuscivo a sopportarlo, e avevo il privilegio di poter partire. Quindi l’ho fatto, e non volevo lasciare altro spazio a quella violenza, specialmente non nella mia scrittura. Volevo però scrivere del dolore perché eravamo tutti sotto shock. Ogni volta che qualcuno muore, il fatto si ripercuote su molte persone. Lo stesso accade quando qualcuno scompare, sebbene in modo diverso e ugualmente orribile, perché non c’è una reale conclusione. Quindi scrivere del dolore è stato il mio modo di dare spazio a tutto questo.
VL: Anche il titolo parla di questo?
LJ: Sì. L’umami è un sapore che è molto difficile da individuare. Cambia completamente il gusto del cibo, e spesso viene confuso con il dolce o il salato. Anche il dolore è così. A volte ne sei completamente sommerso; altre volte, semplicemente permane come un retrogusto, discreto ma ancora abbastanza potente da influenzare il modo in cui sperimenti la vita.
VL: Mi ricordo un pezzo che hai scritto anni fa. Era una diatriba contro la barbabietola.
LJ: Veramente ora le adoro.
VL: (ride, ndr) Be’, allora detestavi la barbabietola, e dicevi che sapeva di addio. Il che mi fa venire in mente un’altra cosa. In quanto scrittrici che vivono fuori dal Messico, e che fanno spesso reading e interventi in paesi stranieri, ci si aspetta in qualche modo che rappresentiamo il Messico. Anche se non siamo ambasciatrici culturali di alcun tipo, e anche se non rappresentiamo nulla – sono sicura che sarai d’accordo – spesso ci viene chiesto di parlare non solo dei messicani, ma anche di raccontare l’attuale versione mondiale del Messico. Si pensa che gli scrittori messicani debbano parlare di droga e violenza e comportarsi sempre come esperti dei problemi della nazione.
LJ: Immagino che dagli scrittori francesi ci si aspetti di parlare di sesso o qualcosa del genere.
VL: Che è molto più bello. Ho un amico, brasiliano, che mi ha raccontato: «Sono andato a fare un tour di presentazioni in Inghilterra per l’uscita del mio libro, poco tempo fa, e ho tenuto questo discorso supermeticoloso in inglese, cosa difficile per me, su come ho costruito quest’architettura molto difficile, sui problemi di accento, ritmo, personaggi, e così via». E alla fine qualcuno dal pubblico…
LJ: …ha fatto una domanda sul calcio?
VL: No, sul virus Zika. «Puoi parlarci un po’ di più del virus Zika?» In quanto scrittrici latinoamericane, o scrittrici di un paese cosiddetto del terzo mondo, ci si aspetta da noi che ci limitiamo ai temi solitamente assegnatici. Ci è permesso parlare solo di questo e, nel caso di scrittori messicani, siamo considerati interessanti solo se possiamo portare al mondo storie di violenza, povertà, droga. Ovviamente, sono cose che non ci fanno dormire la notte. La situazione in Messico è un labirinto in cui passo molte notti insonni. Ma in quanto scrittrice che vive all’estero tu come vivi dover parlare di queste cose?
LJ: A volte mi sembra molto fastidioso e ingiusto, perché non capita la stessa cosa ad autori statunitensi o inglesi, ma mi sembra anche un incredibile privilegio essere uno scrittore e poter fare quello che ti piace e poterne parlare. Non mi dà più fastidio come un tempo, perché è un’opportunità per raccontare alle persone cose che non sanno e fargli presente quanto il Messico sia un paese incredibile, complesso, cosmopolita e antico, e quanto è ingiusto che sia ridotto a una zona di guerra quando ci sono così tante persone che stanno ancora costruendo la loro vita lì ogni giorno.
VL: Pensi che sia un nostro dovere, in quanto scrittrici di un paese che è così incasinato, sensibilizzare l’argomento e dare un quadro più complesso alle persone del resto del mondo?
LJ: No, non credo. Penso però che sia il nostro dovere rispondere alle domande che ci vengono poste quando interveniamo in pubblico. Tristemente, tendono ad andare in quella direzione, e molte volte uno finisce per dire: «Non sono un’esperta».
VL: Credi che la fiction giochi un ruolo importante in un momento di crisi politica come quella attuale in Messico?
LJ: Mi faccio costantemente questa domanda. Non credo di avere una buona risposta. Quando vivevo lì e qualcuno mi chiedeva se mi sentivo una scrittrice messicana, rispondevo: «No, non mi sento una scrittrice messicana. Mi sento una scrittrice in Messico». Il che ha diversi significati. Significa essere una scrittrice donna in un mondo e in un paese estremamente machisti. Significa anche vivere nella violenza e in tutto quello che sta succedendo in questo periodo. Quindi non credo che sia nostro dovere fare esplicito riferimento alla situazione politica nel nostro paese. Il nostro unico dovere è scrivere meglio che possiamo. Sono però arrivata a pensare che più la tua figura diventa pubblica, più è necessario trovare un modo di affrontare il problema, perché le domande non si fermeranno di certo.
VL: No, e sono valide e importanti, in ogni caso. C’è una grande differenza tra la narrativa internazionale sul Messico e la narrativa messicana che parla del paese. Gli scrittori hanno il difficile ruolo di intermediari. Nei circoli internazionali d’élite ci si aspetta che gli scrittori messicani “internazionali”, i barbari civilizzati del sud, riflettano e allo stesso tempo contraddicano la narrativa nazionale, forse per far sì che gli intellettuali benpensanti possano confermare le loro benintenzionate credenze su di noi. Allo stesso tempo, in Messico, quegli stessi scrittori sono visti come borghesi scollegati dalla realtà che non sono autorizzati a dare la propria opinione, perché parlano da una situazione di privilegio assoluto. In un mondo, siamo piccoli brillanti emarginati, nell’altro siamo oppressori.
LJ: Hai ragione, è una questione molto contradditoria. Ognuno è autorizzato ad avere un’opinione e, avendo ricevuto attacchi di questo tipo, mi fa male. Eppure non rispondo mai. Non vedo che senso potrebbe avere. La mia scrittura dovrebbe sempre parlare di per sé. Volevo raggiungere un pubblico messicano più ampio, quindi dopo la pubblicazione del romanzo – solo a una piccola minoranza di messicani sembra importare qualcosa – ho scritto la sceneggiatura per un film, una commedia commerciale, una satira che è anche una critica politica. Ma non volevo scrivere per persone che già la pensavano come me. Volevo scrivere per persone che non avevano nulla in comune con me, ma che sarebbero andate a vedere un film. Forse posso comunicare con loro. Una delle gioie che Umami mi ha regalato è che piace ai lettori stranieri quanto gli potrebbe piacere un libro di qualunque altro posto.
VL: Certo, perché Umami non si prefigge di «rappresentare» niente di specifico. Non è un pamphlet ideologico o una guida di viaggio per un altro paese terzomondista. È un romanzo che parla di complesse relazioni umane in una complessa metropoli.
LJ: Per tornare a quest’idea di dovere, l’unica cosa che sentirei come un dovere in quanto scrittrice messicana è dare spazio a personaggi femminili complessi. Credo sia importante perché semplicemente non lo vedo succedere molto spesso.
VL: Be’, l’altro giorno stavo tenendo una lezione sui Detective selvaggi di Roberto Bolaño, un libro che adoro. Mi ha sorpreso la reazione delle studentesse. Erano incazzatissime per il contenuto immensamente machista del libro. C’è una parte in cui i personaggi stanno parlando di poetesse messicane. Uno di loro dice: «Sposti un sasso e sotto ci trovi una ragazza che scrive le sue cosette». Con tutto il machismo con cui siamo cresciute leggendo in spagnolo e al quale non abbiamo mai reagito – mi ricordo che la prima volta che mi sono incazzata nella mia cosiddetta esperienza professionale è stato quando ho iniziato a scrivere per una rivista in Messico. L’editore della rivista mi aveva chiesto una recensione, e dopo mi aveva anche fatto molti complimenti. Mi ha chiesto se avessi voglia di scriverne altre, perché, disse, avevano bisogno di più scrittrici donne. Quella è stata la prima volta che ho pensato, Merda, così non va bene. Mi volevano perché avevano bisogno di donne. Azione positiva che, quando viene applicata su di te così apertamente, è un po’ deludente.
LJ: Lo capisco, ma credo comunque che in Messico ci sia bisogno di più donne. Lo credo davvero, perché le cifre sono davvero tristi. Nella realtà, ma anche nella finzione. Se sfogli alcuni dei maggiori libri messicani degli ultimi dieci anni, sono bellissimi, ma non c’è una sola donna, e se c’è, è sempre la madre. È sempre o la mamá o la puta. La madre o la puttana.
VL: In Messico, ci sono solo due donne che tutti amano, la Vergine di Guadalupe e Sor Juana Inés de la Cruz. Una è una madonna e l’altra è una monaca. È assurdo.
LJ: Quando hai una voce narrante femminile, non importa quanto sia complessa, anche i critici messicani più seri diranno: «È un libro così femminile!» L’altra cosa che mi chiedono spesso è: «Come hai fatto a creare una voce maschile così convincente?»
VL: Sì, l’hanno chiesto spesso anche a me.
LJ: In qualche modo, le voci maschili sono più facili da ricreare, perché tutto quello che ci hanno insegnato come letteratura è stato scritto da uomini bianchi di mezz’età. Oggi, soprattutto quando tengo dei workshop, lo faccio subito notare ai miei studenti, gli dico: «Se il tuo personaggio è machista…»
VL: Sono gli altri che lo fanno notare a te, credo che questa sia la differenza adesso.
LJ: Non così tanto, in Messico. In ogni caso, io non sto parlando di essere politically correct. Se il tuo personaggio è machista, che sia il più machista possibile. Semplicemente bisogna riconoscere che se tutto nel tuo libro è machista e tu non te ne rendi conto perché è in quel modo che vedi il mondo, sei in un vicolo cieco.
VL: I messicani sono molto politically incorrect. Hanno sempre disdegnato la political correctness statunitense. Io stessa l’ho fatto finché non mi sono trasferita negli USA. Ora, faccio queste discussioni infinite con la mia famiglia quando li sento dire cose orribili. Credo che la violenza, sociale o personale che sia, inizi con il linguaggio, che è molto più potente di quanto pensano le persone. Come scrittrice, cosa pensi dell’essere politicamente corretto?
LJ: Nella vita, credo che rispettare gli altri sia la cosa in assoluto più importante, molto più importante della letteratura. Nella scrittura, però, non credo che dovremmo preoccuparcene. L’unica cosa che conta è la coerenza del personaggio. L’altro giorno stavo parlando con uno sceneggiatore che conosco, sposato con una sociologa. Dice che fa sempre leggere le sue sceneggiature alla moglie, che gli fa vedere dove tutti i suoi personaggi si stanno comportando in modo machista. E io gli ho risposto che è proprio per questo che io non faccio leggere le mie cose a mio marito, anche lui sociologo. Per me non ha senso desiderare che tutti i miei personaggi siano ugualmente sensibili e che il mio mondo narrativo sia così distaccato dalla sporca attualità della vita umana.
VL: L’altro giorno ho sentito un intervento di Esther Allen, una traduttrice bravissima. Ha parlato di quando, non molto tempo fa, negli Stati Uniti gli editor dicevano, senza alcun tipo di autocontrollo, che non pubblicavano scrittori in traduzione. È come dire che non pubblichi le donne o i neri.
LJ: È piuttosto triste.
VL: Ma le cose sono cambiate. Oggi, la letteratura straniera è diventata un prodotto di nicchia nel mercato statunitense. Non credo che un editore oggi direbbe mai, almeno non a voce alta, che non pubblica scrittori in traduzione.
LJ: Sarà di nicchia per un po’, ma credo che le cose stiano lentamente cambiando. Sta già succedendo con Elena Ferrante, con Bolaño, e con il successo di Karl Ove Knausgård.
VL: Poco tempo fa ho letto la Ferrante in italiano, e non mi è piaciuto molto.
LJ: No, nemmeno a me.
VL: Ne ho parlato con un po’ di amici italiani. Per loro, il problema con la Ferrante, che è un’autrice molto capace, è che diventa una sorta di riproduzione di seconda mano dell’italianità, facilmente digeribile per chiunque altro. Immagino che gli scrittori italiani debbano avere a che fare con gli stessi problemi che si pongono agli autori messicani: diventeranno successi commerciali fuori dall’Italia sono se incarnano molto bene un cliché. In un caso, si tratta di violenza e droga, in un altro, è una specie di nostalgia in stile Nuovo Cinema Paradiso in cui le nonne stendono i panni alla finestra e i bambini corrono liberi e selvaggi per il quartiere.
LJ: È vero, ma ci sono anche casi contrari. I tuoi libri, per esempio, non sono in alcun modo una caricatura del Messico, eppure sono tradotti in molte lingue.
VL: Okay, un’ultima domanda. Che libro hai sempre sentito di dover leggere, ma non l’hai mai fatto?
LJ: I detective selvaggi. Be’, ho letto la prima parte e poi mi sono fermata.
VL: Perché le interviste della seconda parte sono un po’ noiose?
LJ: Forse. Non mi ricordo perché, ma ho perso interesse.
VL: Quando l’ho letto io ho adorato la prima parte. Quella scena in cui il narratore sta leggendo un libro e ha un’erezione all’Alameda Central, un parco a Città del Messico, e poi vede uno scoiattolo orribile, e l’eccitazione gli passa subito. È una scena che fa molto Città del Messico. Tutti fanno sempre sesso nei parchi, e poi arriva lo scoiattolo e rovina tutto. Perché le persone in Messico si coccolano così tanto in pubblico?
LJ: Perché vengono da famiglie cattoliche, e a casa non possono fumare o scopare?
VL: Gli spazi pubblici sono i veri spazi di intimità nei paesi cattolici.
LJ: Se dovessimo parlare come scrittrici francesi, quante storie potremmo raccontare…
This interview, Laia Jufresa by Valeria Luiselli, was commissioned by and first published in BOMB magazine 137, Fall 2016. © Bomb Magazine, New Art Publications, and its Contributors. All rights reserved.
The original article and BOMB’s Digital Archive can be viewed at http://bombmagazine.org/articl
Condividi

