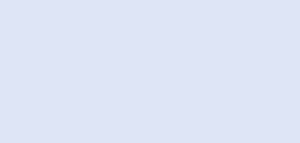 Torniamo a parlare di Lucia Berlin, con un ritratto apparso sul blog della Paris Review. Ringraziamo la testata.
Torniamo a parlare di Lucia Berlin, con un ritratto apparso sul blog della Paris Review. Ringraziamo la testata.
di Elizabeth Geoghegan
traduzione di Giuliano Velli
Non era politicamente corretta, Lucia Berlin. E non era New Age. Non parlava mai di «recupero» o «karma». Non abbiamo mai discusso dei Dodici Passi. Si sapeva che ormai era pulita. Non c’era motivo per discuterne, specialmente quando poteva scriverne. Nei suoi racconti, abitati da alcolisti e tossicodipendenti, riecheggiano le devastanti circostanze della sua vita, rese con un’empatia, un disgusto e un umorismo spietato. Aveva fatto avanti e indietro tra l’emarginazione, il benessere e la disintossicazione, e sembrava improbabile che una come lei finisse a Boulder, Colorado, un posto invaso da massaggiatori, sportivi estremi e vegani. Eppure è lì che trascorse gran parte dell’ultimo decennio della sua vita. Dapprima in una casa di legno stile vittoriano sotto le rocce rosse di Dakota Ridge, e in seguito, ridotta in miseria dalla malattia, in un parcheggio per roulotte alla periferia della città immacolata.
Sapere della roulotte mi aveva depresso, finché non riuscii ad andarla a trovare, scoprendola a proprio agio tra le squallide case di metallo logoro accatastate sui blocchi di cemento. È probabile che Lucia si sarebbe sentita più a suo agio nel guardare un toro trafitto nell’arena di Città del Messico, o accalcata in un angolo di Oakland tra i vagabondi alcolizzati, di quanto lo sia mai stata nella sua prima casa della snob Mapleton Hill. Ma quasi tutto il nostro tempo insieme lo abbiamo trascorso lì. Di solito al suo tavolo da cucina.
Prima che l’avessi mai incontrata, Lucia mi aveva lasciato un messaggio in segreteria su un racconto che avevo scritto. La sua voce affannata, dolce e sensuale mi aveva fatto un po’ innamorare; come nella sua scrittura, era la sua voce a catturarti. Quando ci siamo incontrate, scoprire che era decenni più vecchia di quanto avevo immaginato era stato uno shock. Era come la protagonista di «B.F. and Me», quando dice: «Ho davvero una bella voce. Sono una donna forte, persino crudele, ma a causa della mia voce tutti pensano che sia una persona davvero gentile. Nonostante i miei settant’anni sembro ancora giovane, e i ragazzi del Pottery Barn ci provano con me». Certamente gli uomini ci provavano con lei, ma Lucia non era mai crudele, nonostante la sua voce celasse una vena diabolica.
Poche settimane dopo esserci conosciute, l’altitudine elevata aveva compromesso il suo già fragile sistema respiratorio (uno dei polmoni era stato schiacciato dalla scoliosi che la tormentava da bambina), ed era stata messa sotto ossigeno. Non l’ho più vista senza un serbatoio di ossigeno, se non quando mi mandava al Lolita’s Deli in bici a prendere le sigarette. Le sigarette sfuse costavano venti centesimi l’una. Ha sempre chiesto le più forti. Lucky Strike, Marlboro rosse. Compravo una Camel Light a testa e tornavo a casa sua pedalando. Faceva scivolare via il tubo per l’ossigeno e le accendevamo, concedendoci l’unica sostanza assuefacente che potevamo ancora permetterci di usare. Il fatto che incombesse la minaccia dell’esplosione della bombola d’ossigeno serviva solo a rendere il tutto più divertente. La scarica che accompagna il corteggiamento del pericolo è sempre l’ultima ad andarsene. Come la protagonista dell’esilarante racconto «502», ogni tanto Lucia aveva «l’urgenza diabolica di incasinare tutto». Ma poi c’era il modo in cui a metà sigaretta, con un barlume di panico, afferrava il lungo tubo dell’ossigeno avvolgendolo sulla testa e sotto il naso.
Anche così, riusciva a sorridere, affannosamente.
Ripenso a quei momenti con una dose uguale di rimorso feroce (come potevo permetterle di fumare?) e delizia: non c’erano momenti più dolci di quelli in cui parlavo con Lucia. Eravamo cresciute entrambe con genitori alcolizzati e violenti, le nostre vite scandite dalla perdita. In misura diversa, tutte e due avevamo messo alla prova con noncuranza i limiti delle nostre dipendenze. Quando ci siamo incontrate eravamo pulite da diversi anni, e condividere una sigaretta furtivamente era la nostra piccola ribellione contro il salutismo ipocrita di Boulder, dove, come Lucia ha scritto, «anche i corridori sembrano appena usciti dalla doccia». E poi avrei potuto restare ad ascoltarla per sempre, lì al suo tavolo da cucina. Spesso parlavamo di libri, ma in verità parlavamo un po’ di tutto. Non avevo mai conosciuto nessuno che sapesse usare la parola adoro meglio di lei. Adorava Murakami, Lydia Davis, Cechov. Anni dopo, mi scrisse lamentandosi della difficoltà di trovare qualcun altro con cui poter parlare «di scarpe e di libri, di morte e di pettegolezzi».
Come quasi tutti i grandi narratori, Lucia era una pettegola di prim’ordine. Ma i suoi pettegolezzi non erano mai banali. I migliori riguardavano la sua vita. Però, pensare di aver compreso la sua biografia, credere di sapere di quale figlio o marito parlava uno specifico racconto, poteva essere rischioso. Figuriamoci confondere le relazioni, gli aborti e i suicidi dei suoi racconti con quello che era veramente accaduto. Aveva vissuto in ogni parte del mondo, parlato diverse lingue, all’età di trentadue anni si era sposata e aveva già divorziato tre volte. Aveva cresciuto quattro figli, frequentato la scena jazz newyorkese, bazzicato i poeti Beat e Black Mountain, stipato i suoi bambini su un aereo privato per andare a vivere in una capanna con il tetto di paglia e il pavimento di plastica in Messico, sulla costa del Pacifico. Attraversò, in modo non lineare, vite e mondi. Leggendo di tutto. Conoscendo tutti. Se, per dire, volevate lo scoop sui flirt di Ava Gardner con i camerieri a bordo piscina di Puerto Vallarta, dentro e fuori dal set dell’adattamento della Notte dell’iguana di John Huston, Lucia c’era stata. Poteva raccontarti di come uno di loro aveva truffato Ava, fregandole una barca.
Ma non vantava mai conoscenze importanti per il gusto di farlo, la sua vita era proprio così. La sua scrittura ne fu influenzata? Ovvio che sì. Avrebbe potuto scegliere l’autobiografia, ma penso sapesse che era destinata a una forma d’arte superiore. Leggerla significa perdersi nella sua voce. I suoi racconti ti fanno sentire come se stessi spettegolando a tavola con lei. I movimenti della sua narrativa mimano la natura erratica di una conversazione privata, e anche quelli della sua vita vagabonda. Può trasportarti dagli alcolisti di El Paso ai carcerati di Oakland con la stessa facilità con cui può farti credere di essere capace di caricare una dose letale nella siringa del marito tossicodipendente prima di andare in ospedale a partorire. I suoi racconti si dispiegano in modi così inattesi che quasi dimentichi dove era cominciata la storia. Poi ti riporta indietro all’improvviso e ti toglie il fiato con uno dei suoi inconfondibili finali.
I confronti tra la sua opera e quelle di Raymond Carver e Richard Yates sono inevitabili, ma io non li condivido. Sì, ha scritto dei poveracci, ma il suo proposito era più letterario, la sua prosa è erede di Proust, di Cechov. Dove l’opera di Carver è eccessivamente artificiosa – e ti ricorda continuamente che stai leggendo un racconto breve di Raymond Carver – lo stile di Lucia è più organico e sorprendente. Dove le storie di Yates sono rigide fino all’intransigenza, quelle di Lucia sono fluide, irriducibilmente femminili. I suoi personaggi sono quasi sempre donne. Ammirava entrambi, ma non emulò mai né l’uno né l’altro. Né scadeva nell’ironia facile. I suoi racconti, invece, ti cullano in un falso senso di sicurezza, ti distraggono con l’umorismo, e poi ti fanno scorrere il rasoio sulla pelle, e ti abbandonano in un posto che non avresti mai voluto visitare.
Mi sono chiesta spesso perché ci sia voluto così tanto affinché l’opera di Lucia ottenesse l’attenzione che merita. Penso di sapere il perché. E penso lo sapesse anche lei. Ma finora non lo avevo capito. Una volta mi raccontò di aver vinto una borsa di studio del National Endowment for the Arts. L’aveva usata per andare a Parigi, spendendola tutta senza scrivere nemmeno un rigo. Più tardi, spedì al NEA una lettera di ringraziamento in cui raccontava cosa aveva fatto con i soldi: tutto, tranne scrivere. Ovviamente, ironizzò sul fatto che dopo di allora non aveva più vinto altri premi. Io e Lucia possiamo non aver mai parlato di disintossicazione, è vero, ma se avete letto le sue storie, sapete quanto erano avvilenti le sue condizioni. Trafficare droga attraverso il confine, incinta. Svegliarsi in comunità di recupero. E di peggio. Ma quella era la materia di cui è fatta la finzione narrativa, infusa di umorismo feroce, un umorismo possibile solo quando si racconta il passato. Gli eventi della vita reale erano tutt’altro che divertenti. Qualsiasi quantità di fama o successo avrebbe potuto metterla in crisi. Dopo tutto quello a cui era riuscita a sopravvivere, che qualcosa improvvisamente andasse per il verso giusto avrebbe anche potuto segnare la sua rovina. E non ci sarebbe mai ripassata, anche a costo di rimetterci la carriera.
Col senno di poi, capisco che la ricercatezza di Boulder, per quanto potesse sfiancarla, le ha anche fornito il materiale e la necessaria stabilità per produrre una nuova raccolta. La vicinanza con tanti amici cari sedò anche la sua ricerca, lunga una vita, di una casa. Ma Lucia aveva a lungo inseguito la morte nelle sue storie, e ora sembrava che la morte inseguisse lei. Alla fine si trasferì vicino ai suoi figli e nipoti in California. Sentivo il bisogno di vederla un’ultima volta, così volai fin lì da Roma. Mi accolse sul cancello del giardino, trascinandosi dietro il tubo dell’ossigeno. Gli stupefacenti occhi blu di sempre. La sua voce esattamente come la ricordavo. Ma adesso era continuamente a corto di fiato, e la sua malattia l’aveva resa timida. Detestava l’idea che qualcuno potesse preoccuparsi o dispiacersi per lei. Ormai era troppo malata per fumare, ma ci siamo sedute insieme al tavolo della sua cucina, dove così tante delle sue storie erano state scritte e raccontate, chiacchierando come avevamo sempre fatto.
Quando sono tornata in Italia, ho ricevuto un’ultima lettera da Lucia. Era brevissima, la scrittura caotica e sbrigativa. Leggendola, mentre mi confessava l’urgenza di mettere su pagina, finché poteva, i suoi ultimi racconti, mi sembrava di sentire la sua voce meravigliosa, anche mentre scherzava sullo stato «pietoso» della sua produzione letteraria. Concluse la lettera come concludeva tutto quello che scriveva: con un’ultima riga impressionante. «Scritta sulla mia lapide: Mozzafiato».
© Elizabeth Geoghegan, 2015. Tutti i diritti riservati.
Condividi

