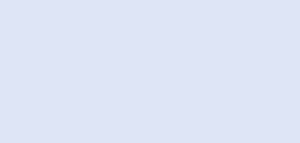 [1]Pubblichiamo un ricordo del songwriter americano Merle Haggard, recentemente scomparso. L’articolo, firmato da Lorin Stein, è apparso originariamente sul blog della Paris Review [2]. Ringraziamo l’autore e la rivista.
[1]Pubblichiamo un ricordo del songwriter americano Merle Haggard, recentemente scomparso. L’articolo, firmato da Lorin Stein, è apparso originariamente sul blog della Paris Review [2]. Ringraziamo l’autore e la rivista.
di Lorin Stein
traduzione di Antonio De Sortis
Fin da quando ho iniziato a lavorare come editor alla Paris Review, avrei voluto pubblicare un’intervista a Merle Haggard. Nessun altro cantautore conta così tanto nella mia vita. Sfortunatamente, la Review non ha una sezione sull’Arte del Songwriting (e per buoni motivi), perciò per questi sei anni è rimasto soltanto un desiderio. Poi venerdì scorso, al matrimonio di un amico, ho conosciuto una deejay country di nome Rebecca Birmingham. Ci siamo trovati a parlare di Merle e di quanto ci commuovono le sue canzoni, di quanto siano autentiche, di quanto suonino originali ancora oggi. Entrambi sapevamo che aveva problemi di salute, aveva problemi di salute da anni, ma lei aveva un’amica che sapeva come mettersi in contatto… Quattro giorni dopo ci è arrivata la notizia che era morto.
Il titolo del necrologio di Haggard sul New York Times l’ha definito «un cantore dell’uomo comune» [3]. Lo era, certamente. Quando Merle pubblicò i suoi primi singoli, all’inizio degli anni Sessanta, aveva trascorso metà della sua vita adulta in prigione, e nelle sue canzoni scriveva in maniera eloquente – per un pubblico di massa – della vita in carcere, della vita usciti dal carcere, dei guai con la legge. Io e mia sorella cantavamo quelle canzoni con nostro padre, praticamente da quando abbiamo imparato a parlare. Ricordo di aver chiesto conto a mio padre del ritornello esplosivo di «Mama Tried»: «I turned twenty-one in prison, doing life without parole» [«Ho compiuto ventun anni in prigione, ergastolo senza condizionale»]. Capivo le parole, ma il tempo al passato mi disorientava e sconvolgeva. Non significava forse che l’uomo che cantava era ancora in prigione… e ci sarebbe rimasto per sempre? Quel ritornello è la chiave della canzone. Parla di essere già stati condannati all’ergastolo. Un verso che viene dall’oltretomba.
Via via che crescevo cantavamo di meno tutti insieme, e io ascoltavo più dischi. In quel periodo – fra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta – Merle aveva ancora successi che passavano in radio. Queste canzoni non parlavano tutte di prigione, o dell’essere cresciuti nella Dust Bowl e nei campi petroliferi. Il suo disco del 1979, Serving 190 Proof, non c’entra niente con l’uomo comune. L’inizio della prima canzone, «Footlights», dice: «I live the kind of life most men only dream of» [«Vivo la vita che la maggior parte degli uomini può solo sognare»].
I make my living writing songs and singing them.
[Mi guadagno da vivere scrivendo canzoni e cantandole.
But I’m forty-one years old, and I ain’t got no place to go when it’s over,
So I’ll hide my age and take the stage
And try to kick the footlights out again.
Ma ho quarantun anni, e non ho un posto dove andare quando è finita,
Allora nascondo la mia età e salgo sul palco
E provo a far venire giù le luci anche questa volta.]
Le canzoni di Serving 190 Proof parlano di giovinezza che sfuma, di nascondere e autocurarsi la depressione, finire dallo strizzacervelli, vedere un matrimonio cadere a pezzi, sentirsi schiacciati allo stesso modo dal successo e dal fallimento. Sul disco ci sono anche pezzi country convenzionali. Ma Merle aveva trovato una nuova vena. Gli anni Ottanta li avrebbe spesi a registrare versi confessionali diversi da tutto ciò che era stato fatto prima. Le donne nelle sue canzoni divennero persone specifiche. I testi non erano più «country» in senso stretto:
The first time we met is a favorite memory of mine.
[Il nostro primo incontro è un ricordo che ho caro.
They say time changes all it pertains to,
But your memory is stronger than time.
Dicono che il tempo cambia tutto ciò che gli appartiene,
Ma il tuo ricordo è più forte del tempo.]
Le canzoni divennero, per un bambino, quasi troppo tristi da ascoltare. Ma difficili da evitare, come un segreto che non vuoi sentire.
Serving 190 Proof uscì che avevo sei anni. Un anno dopo i miei genitori divorziarono. Mio padre, ora mi sovviene, all’epoca aveva quarantun anni. Ora io ne ho quarantadue, e quando riascolto quelle canzoni, ciò che noto è quanto fossero attente alla solitudine dell’età matura – non propriamente la sofferenza romantica, non lo struggimento, ma la sensazione di essere condannati, impotenti, consumati dal rimorso. Nelle canzoni questo sentimento era, in qualche modo, specificamente maschile e come ineffabile, incomunicabile. Le canzoni erano il buco della serratura di una cella.
La settimana scorsa, a quel matrimonio, ho capito che non avevamo bisogno di inventare un nuovo genere per Merle. La sua arte era l’Arte della Nonfiction. Quindi ho assegnato l’intervista quella sera stessa, a una persona che fino ad allora non conoscevo, sei anni in ritardo.
Potete ascoltare qui [4] l’omaggio di Rebecca a Merle sulla WFMU. Contiene degli stralci dal disco del 1972 Let Me Tell You About a Song, in cui Merle riassume la genesi di alcuni dei suoi primi lavori. Per gli ascoltatori interessati, consiglio le sue autobiografie My House of Memories e Sing Me Back Home, e il profilo che ne fa Nicholas Dawidoff nel libro In the Country of Country del 1997.
© Lorin Stein. 2016. Tutti i diritti riservati.
Lorin Stein è l’editor della Paris Review.