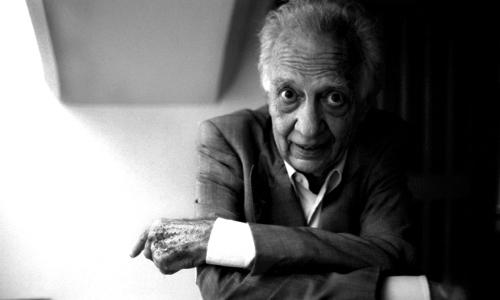 Pubblichiamo oggi un approfondimento dello scrittore messicano Álvaro Enrigue su Sergio Pitol. L’articolo è uscito su Letras Libres, che ringraziamo.
Pubblichiamo oggi un approfondimento dello scrittore messicano Álvaro Enrigue su Sergio Pitol. L’articolo è uscito su Letras Libres, che ringraziamo.
«Sergio Pitol, bambino russo»
di Álvaro Enrigue
traduzione di Dajana Morelli
È stato il traduttore di Conrad e James, il curatore di libri insoliti, ma soprattutto lo scrittore che ha scommesso sull’eliminazione delle frontiere tra generi. Nella sua opera, la realtà acquisisce senso solo attraverso la scrittura.
C’è una storia che Sergio Pitol raccontava spesso quando ancora appariva in pubblico e della quale ha lasciato traccia scritta in El arte de la fuga. Agli inizi degli anni Ottanta passò due mesi di vacanze a Città del Messico, dopo aver vissuto per anni a Barcellona, Varsavia, Budapest, Mosca. Aveva, a quei tempi, quarantacinque anni e sei o sette libri pubblicati; era già il traduttore di Conrad e Henry James ed era stato il curatore della leggendaria collana di libri «Los Heterodoxos», pubblicata dalla casa editrice Tusquets in Spagna e con un’ampia circolazione in tutta l’America. Poco dopo essere arrivato in Messico, ricevette una chiamata dal PEN Club in cui lo invitavano a partecipare a una serie di dialoghi tra scrittori di generazioni diverse – una lettura, seguita da una conversazione pubblica, tra un autore consacrato e uno giovane. Accettò e gli annunciarono che avrebbe letto con Juan Villoro. L’evento fu quasi un disastro perché Pitol, ventitré anni e un sacco di libri più vecchio di Villoro, pensava, fino a quando non salì sul palco, di essere lui quello giovane al tavolo. Non c’è niente che ritragga meglio la sua condizione di eccentrico: era una figura di riferimento per tutta una letteratura e continuava a pensare a sé stesso come a una promessa letteraria.
È questa condizione di eccentrico sine qua non ciò che ha permesso a Pitol di convertirsi dapprima in un autore di culto e poi nello scrittore che ha rimesso in circolo una splendida tradizione secolare della letteratura messicana: quella degli autori di libri senza generi, più disposti a proporre una conversazione che a imporre una solida idea del mondo mediante una finzione popolata di aneddoti e personaggi simbolici.
Letti nell’ordine in cui sono stati pubblicati, i libri di Pitol raccontano la storia di un distacco. L’autore che iniziò scrivendo racconti stupefacenti ma convenzionali sulla remota regione del Messico in cui è cresciuto lentamente si è liberato dai temi e dai linguaggi che ottenevano prestigio durante il XX secolo: la peculiarità di una cultura regionale, la rilevanza della nazionalità, l’anima latinoamericana nelle solitudini dell’esilio.
Simultaneamente a questo distacco – allora suicida – dai temi collaudati della scrittura regionale, Pitol mise in pratica un esperimento più rischioso: distaccarsi anche dalle superstizioni della forma letteraria – o forse espanderle. I suoi libri, poco a poco, smisero di essere romanzi o antologie di racconti o saggi per trasformarsi in sessioni letterarie nelle quali la distanza tra finzione, riflessione e memoria è irrilevante. Libri che sono tutto allo stesso tempo, ciò che Salvador Elizondo, suo contemporaneo, chiama, tra il filosofico e l’ironico, «libri da leggere».
Nel momento della pubblicazione di El arte de la fuga e El viaje il gesto di abiurare i generi venne inteso come provocatoriamente postmoderno: affinché una scrittura fosse totale, doveva prescindere dalle convenzioni del mercato che asfissiavano le letterature latinoamericane durante la fine del XX secolo, in cui i grandi gruppi editoriali sembravano aver imposto un gusto letterario corto e piatto come unica opzione nelle librerie.
Passato il tempo, si può vedere con chiarezza che, se è vero che l’acclamazione ricevuta da entrambi i libri fu imprevista, è anche vero che Pitol non stava agendo come un innovatore disperato, ma come l’attento lettore di una tradizione che ha sempre trovato claustrofobici i generi letterari. Nemmeno i libri di Martín Luis Guzmán, Nellie Campobello, José Vasconcelos o Alfonso Reyes – fondatori della modernità letteraria messicana – avevano un genere trasparente. Nella stessa generazione di Sergio Pitol, brillante e poco seguita al di fuori dell’America Latina, autori come Margo Glantz, Alejandro Rossi o lo stesso Salvador Elizondo non smisero mai di insistere sul fatto che la produzione letteraria più resistente del paese era radicata in scritture svincolate dalle convenzioni dei generi.
I libri della maturità di Sergio Pitol non sono, quindi, capricciosi. Hanno le loro fondamenta in una tradizione e sono il prodotto di un procedimento al quale ha lavorato, in maniera consistente e serena, negli ultimi vent’anni: l’esperienza umana manca di valore fino a quando non si trasforma in scrittura, ma se a questa scrittura si impone la geometria ottusa di un genere, si tradisce la sua fondazione irrazionale. «L’ispirazione», segnala Pitol in El mago de Viena, «è il frutto più delicato della memoria». Non è un’idea nuova: è presente nel profondo della scrittura di Sant’Agostino, di Montaigne, di Albert Camus. Per l’autore, il genio che muove la letteratura è quello della corrispondenza: ciò che sperimentiamo, in base a quanto dice lui stesso, è soltanto «un insieme di frammenti di sogni non del tutto compresi».
È per questo che El arte de la fuga comincia con la descrizione miope di Venezia: per poter vedere ciò che ha valore nel mondo, bisogna lasciare gli occhiali quotidiani sulla scrivania. La realtà è lì, ma è significativa solo quando viene smontata da quello che è stato cancellato, che implica selezionare e fare il montaggio di una serie di episodi, letture, appunti. È anche per questo che El viaje include saggi, ma anche pagine di giornale, aneddoti, racconti così circolari da non poter essere assolutamente veri ma che sono raccontati come se lo fossero. L’immaginazione letteraria, secondo Pitol, non progredisce secondo l’ordine razionale che richiedono un romanzo, un saggio o un racconto. Assomiglia più a una spugna marina che a un’autostrada. È un blocco solido, senza appigli, ma pieno di percorsi interiori che connettono idee, appunti, ricordi inventati.
L’inizio di El viaje non potrebbe essere più classico. L’autore, ormai stanco e un po’malato, si rinchiude a scrivere in una specie di Torre di Montaigne tropicale: una città modesta, colta e provinciale del golfo del Messico. Ricorda i suoi anni come ambasciatore a Praga e si accorge che, pur essendo la sua città preferita tra le molte in cui ha vissuto, è anche l’unica della quale non ha mai scritto nulla. Stranito, controlla i diari di quel periodo e scopre un vuoto: contengono solo annotazioni di incontri, letture, irrilevanti problemi d’ufficio; nemmeno una parola sulle sue passeggiate nella città inesauribile, i suoi splendidi musei, la sua potente vita culturale. Quello che sì trova nei suoi quaderni è, invece, un diario di viaggio in Russia che, col passare del tempo, è diventato significativo: registra il momento del disgelo sovietico.
È qui che il procedimento di scrittura di Pitol si fa estremo. Il diario viene riscritto e rivisto affinché venga letto come se fosse un codice guida per un documentario filmato nell’istante in cui la perestroika era ricevuta dalla gente dell’Unione Sovietica con un misto di speranza e scetticismo. Messo in gioco con una serie di saggi sulla letteratura russa, con pagine dedicate ai segreti del mestiere dello scrittore e la proiezione di ricordi le cui connessioni non sono chiare fino a che non si arriva all’ultima riga del volume, il diario produce ripercussioni che lo risignificano man mano che avanza. Non bisogna dimenticare che l’apertura sovietica è avvenuta un po’prima della transizione verso la democrazia in Messico, che è il momento preciso in cui Pitol ha scritto El viaje. Il 2000, anno di pubblicazione del libro, è stato anche l’anno in cui si è conclusa la lunga transizione dei messicani verso un sistema che garantiva, finalmente, tutte le libertà civili di base. La presa in giro dei commissari sovietici e l’elogio ai cittadini impazziti all’idea di libertà rappresentano uno sguardo obliquo alla festa che è stato il Messico in quegli anni strabordanti di speranza.
Ma El viaje non è un libro politico, o è molto di più di questo. È definito da tre scene che riflettendosi tra di loro rivelano la personale visione di un autore nel suo momento di pienezza creativa. Nell’introduzione praghese c’è una scena, a metà tra il terribile e il comico, in cui Pitol, mentre vaga per i vicoli di una delle parti vecchie della città, nota un vecchio steso a terra che insulta i pedoni senza riuscire ad alzarsi. Quando il romanziere si avvicina, scopre che non è ubriaco, ma che è scivolato sulla sua stessa cacca e ogni volta che prova ad alzarsi scivola su di essa. Più tardi, quando alla fine Pitol arriva a Tbilisi, Georgia, prende parte a un pranzo che un’associazione di scrittori e registi di cinema offre in suo onore. È stato, da quando è arrivato, in estasi: la trova sveglia, vibrante, critica, infinitamente più libera e allegra di Mosca o Leningrado. In questo stato di effervescenza, si alza dal banchetto per andare in bagno e, siccome c’è fila, uno dei commensali gli dice di andare a urinare nel fiume, che lì è la normalità. Alticcio per il vino, accetta l’invito e si imbatte in una scena sconcertante: a Tbilisi cagare in pubblico non è soltanto un atto socialmente accettabile, ma anche un’opportunità di socializzazione. Nell’ultimo episodio del libro, Pitol torna alla propria infanzia nel piccolo paese di Potrero, Veracruz, in cui tutta la comunità vive grazie a un’azienda di canna da zucchero. Dato che era un bambino malaticcio, tendeva alla solitudine e all’isolamento. Una delle sue passeggiate preferite consisteva nel perdersi nelle navate della raffineria la domenica – quando era chiusa –, per arrivare nel posto in cui venivano accumulate immense montagne di bagassa, l’inutile merda che rimane dalla produzione della canna di zucchero. Lì, sepolto tra gli scarti vegetali, fantastica sull’illustrazione di un libro per bambini in cui compare un bambino slavo definito come «Ivan: bambino russo» e si percepisce come il suo gemello. In seguito confessa che di tutte le immagini che ha avuto di se stesso, questa – la più delirante – è quella che ancora «gli sembra essere autentica verità».
Il periplo raccontato in El viaje non è, come sembra ad un primo avvicinamento, quello percorso dall’ambasciatore Pitol verso l’Unione Sovietica del disgelo, ma quello del bambino solitario che ha accumulato volti, nomi, viaggi, ricordi, e li ha restituiti in forma di libri. Tra le molte cose che include ci sono gli appunti che l’autore prese per scrivere Domar a la divina garza (La divina) –forse il suo miglior romanzo e un libro davvero selvaggio. Racconta il ritrovamento di un rito di primavera in cui un’intera comunità di Tabasco è sommersa di merda dai suoi abitanti in un parossismo emancipatore.
El viaje è, allo stesso tempo una lezione di finezza e un’astuzia da dinamitardo. È un libro su come si costruisce uno scrittore. Sulla libertà e la sua mancanza, e quella libertà ultima e indomabile che è sciogliersi, lasciare che le cose escano: raccontare. È per questo che il libro lavora sulla mente del lettore non storia per storia, ma nel gioco di riflessi tra una serie di racconti scatologici, un corpo di saggi sulle umiliazioni che subirono gli scrittori russi che optarono per pagare il prezzo di dire quello che volevano, una raccolta di stampe documentali in cui il lettore vede in diretta la generazione sovietica che si emancipò concimata dal sacrificio di quegli autori e il segno autobiografico dello scrittore che ha optato per non attenersi a nessun parametro per arrivare ad essere chi voleva essere: un bambino russo.
C’è una storia memorabile nel diario dell’Avana con cui conclude El mago de Viena: molto giovane e diretto verso l’Europa via mare, Pitol passò per Cuba. Una notte all’Avana prese una sbronza colossale e perse la coscienza. La mattina dopo si svegliò nella sua stanza, con le scarpe di qualcun altro, cosa che lo preoccupa fino a quando non scopre che sono italiane, nuove, magnificamente tagliate e che gli stanno perfettamente. Per Sergio Pitol in tutto c’è tutto e scrivere è l’unica forma di rivelare le segrete connessioni che danno senso alla realtà. La scrittura è lì perché ci rimangano le scarpe.
Questo testo è la traduzione italiana della prefazione all’edizione in lingua inglese di El viaje. Il libro uscirà con il titolo The journey a giugno del 2015, pubblicato da Deep Vellum. La versione in spagnolo è invece apparsa su Letras Libres.
Condividi
